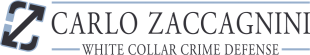Sommario: 1. Cenni introduttivi. – 2. Il caso di specie. – 3. L’evoluzione giurisprudenziale, i due orientamenti. – 4. Considerazioni conclusive.
- Cenni introduttivi. Art. 2901 c.c. – Dell’azione revocatoria. Condizioni
Il presente contributo prende in esame il contrasto giurisprudenziale sorto in relazione al presupposto soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c. in merito all’azione revocatoria di atti dispositivi posti in essere in epoca anteriore al sorgere del credito. La disposizione in esame sancisce quanto segue : “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento ;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
Nodo gordiano riguardava la natura generica o specifica del dolo del debitore da attribuire al requisito soggettivo ex art. 2901 co. 1, c.c., in quanto la diversa definizione dell’elemento soggettivo della fattispecie si ripercuote sia sul piano processuale e sull’individuazione dell’oggetto dell’onere probatorio incombente sull’attore in revocatoria: se l’atto dispositivo viene posto in essere in epoca anteriore al sorgere del credito, l’attore ha l’onere probatorio di provare il dolo specifico del debitore e la dolosa preordinazione di un intento fraudolento; mentre se l’atto viene posto in essere successivamente, l’attore può limitarsi a provare il solo dolo generico e quindi la generica consapevolezza di nuocere alle ragioni del creditore. Il dibattito trae origine sin dal Codice Civile del 1865, nel quale la medesima azione veniva disciplinata dall’art. 1235, il quale, oltre a prevedere soltanto la revocabilità degli atti dispositivi posti in essere in epoca successiva al sorgere del credito, subordinava quest’ultima alla condizione che gli stessi fossero stati “fatti in frode” delle ragioni del creditore. Il significato di tale espressione era controverso, al punto da suscitare non poche perplessità circa le intenzioni del Legislatore.
Quesito di diritto era, dunque, se nell’ideologia del Legislatore, ciò che la norma richiedesse fosse il c.d. animus nocendi, l’intenzione di arrecare danno al creditore, oppure la c.d. scientia damni, ossia la mera coscienza del pregiudizio arrecato ai creditori attraverso la creazione o l’aggravamento di una situazione di insolvenza.
Con la più che recente sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025, le Sezioni Unite del Supremo Collegio affrontano la tematica di cui è commento, risolvendo il contrasto giurisprudenziale rimesso dalla Terza Sezione Civile ed affermando il seguente principio di diritto: “Ai fini della revocatoria di un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, l’elemento soggettivo richiesto ai sensi dell’art. 2901, primo comma, cod. civ., è costituito dalla dolosa preordinazione dell’atto, il che implica che il debitore abbia compiuto l’atto stesso con l’intento di pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro. Pertanto, è richiesta la prova che il debitore abbia agito in previsione del sorgere dell’obbligazione per rendere più difficile o precludere l’azione esecutiva del creditore, e che il terzo acquirente fosse consapevole di tale intento”.
- Il caso di specie.
Nella vicenda processuale in esame, il creditore A.A., in virtù di un assegno bancario emesso in data 30 settembre 2008 e rimasto insoluto, conveniva in giudizio la debitrice B.B. e la società X per ottenere dal Tribunale Ordinario di Roma l’inefficacia di due distinti atti dispositivi stipulati anteriormente il sorgere del credito – in particolare, atto di compravendita stipulato in data 16 settembre 2008 e atto integrativo stipulato in data 06 ottobre 2008 – con i quali la debitrice alienava all’Società X cinque beni immobili, costituenti l’intero assetto patrimoniale di B.B. La Società X si costituiva nel giudizio di prime cure, negando la dolosa preordinazione dell’atto a pregiudicare i diritti del creditore e la propria consapevolezza di tale intenzione. All’esito del giudizio, il Tribunale Ordinario di Roma rigettava la domanda. A.A., dunque, proponeva impugnazione alla Corte d’Appello di Roma, la quale dichiarava inefficaci gli atti impugnati. Ciò in quanto la Corte d’Appello riteneva pienamente configurabile l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., argomentando che quando l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, è sufficiente la previsione di tale pregiudizio (il cd. dolo generico) e, per quanto attiene alla participatio fraudis del terzo, quando l’atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del medesimo pregiudizio. I Giudici del gravame riconoscevano la piena consapevolezza della Società X del pregiudizio volontariamente arrecato dalla debitrice al creditore.
La società proponeva, dunque, ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, eccependo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2901, co. 1, nn. 1-2, c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto che l’atto di compravendita fosse anteriore al sorgere del credito, considerava sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori anziché la preordinazione dell’atto a tale scopo. La causa veniva avviata alla trattazione dinanzi alla Terza Sezione Civile, la quale con ordinanza interlocutoria del 27 novembre 2023 ha trasmesso gli atti alla Prima Presidente, la quale ne ha disposto l’assegnazione alle Sezioni Unite, ai fini della risoluzione del contrasto di cui è commento.
- L’evoluzione giurisprudenziale, i due orientamenti.
Con riguardo all’individuazione dell’elemento soggettivo della revocatoria, nell’ipotesi in cui la stessa abbia ad oggetto un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, nella giurisprudenza di legittimità, prima della pronuncia delle Sezioni Unite in commento, si erano sviluppati due orientamenti interpretativi: l’uno orientato a individuare come requisito soggettivo dell’art. 2901 c.c. la figura del dolo generico, ritenendo sufficiente ai fini della configurabilità della predetta fattispecie la semplice coscienza da parte del debitore del pregiudizio arrecato al debitore; l’altro (ritenuto prevalente) volto invece ad individuare l’elemento soggettivo nella dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito.
A conforto del primo orientamento, con ordinanza n. 5812/2023, la terza sezione della Corte di Cassazione affermava che: “in tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'”animus nocendi” richiesto dall’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie”.
Ed ancora.
“In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo contraente – prevista quale condizione dell’azione dall’art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. – consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l’atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore. Tuttavia, nel caso di contratto preliminare di compravendita a seguito del quale il promittente-venditore abbia alienato il bene oggetto del preliminare ad un diverso soggetto, la prova che l’acquirente dell’immobile fosse a conoscenza del precedente contratto preliminare non è sufficiente, essendo necessaria la prova della sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell’alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito” (Cfr. Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 25614/2014; in senso conforme anche Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 16825/2013).
Tale primo approccio ermeneutico trovava fondamento nell’assunto secondo cui nella gestione del proprio patrimonio il debitore non tiene in considerazione l’interesse del creditore, ma agisce come se lo stesso non esistesse.
Pertanto, secondo tale prospettiva, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della revocatoria era sufficiente la mera coscienza da parte del debitore di determinare o accrescere la propria insolvenza, attraverso il compimento dell’atto dispositivo, mettendo il proprio patrimonio in condizione di non poter offrire ai creditori la garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contratte. Anche con riferimento al secondo orientamento numerosi sono stati gli interventi del Supremo Collegio.
Con ordinanza n. 13265/2024, la prima sezione della Corte di Cassazione affermava che: “in tema di revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l’esercizio dell’azione è, oltre al “consilium fraudis” del debitore, la “participatio fraudis” del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest’ultimo della dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato”.
In senso conforme.
“In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'”animus nocendi” richiesto dall’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. non è sufficiente il dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di stipularlo al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie” (Cfr. Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 16092/2023).
- Considerazioni conclusive.
La sentenza n. 1898/2025 della Corte di Cassazione rappresenta la chiave di volta per la soluzione del suddetto contrasto giurisprudenziale, pronunciando un principio di diritto che appare volto a tutelare maggiormente gli atti di disposizione del patrimonio da parte dei debitori, evitando che vengano compromessi eccessivamente gli interessi dei terzi acquirenti, i quali devono poter godere di una certa sicurezza nelle transazioni patrimoniali.
Gli Ermellini chiarivano che per poter accogliere l’azione revocatoria, è necessario il dolo specifico del debitore, ossia la consapevolezza che l’atto compiuto pregiudichi concretamente la posizione dei creditori, aderendo al secondo orientamento.
Ciò in considerazione del fatto che l’identificazione dell’elemento soggettivo della revocatoria nella mera consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato ai creditori comporta un’indubbia dilatazione dei margini di operatività dell’istituto, poiché in tal senso si ritiene configurabile il presupposto dell’eventus damni non solo in presenza di una compromissione totale della consistenza patrimoniale del debitore, bensì anche a fronte di una variazione quantitativa o qualitativa dello sesso tale da rendere più incerta od ostica la soddisfazione del credito.
Tale dilatazione, difatti, si pone in contrasto con la natura eccezionale che l’azione revocatoria viene ad assumere nell’ipotesi in cui abbia ad oggetto atti dispositivi posti in essere in epoca anteriore al sorgere del credito.
Essa costituisce una deroga al principio generale ex art. 2740 c.c. secondo cui il debitore risponde dell’adempimento “con tutti i suoi beni presenti e futuri”, ossia con quelli esistenti nel suo patrimonio alla data in cui è sorta l’obbligazione e con quelli che abbia acquistato in epoca successiva e non anche con quelli di cui alla predetta data avesse già cessato di essere titolare.
Nel momento in cui il creditore entra in contatto col debitore, il primo è perfettamente in grado di conoscere l’esatta e attuale consistenza e composizione patrimoniale del secondo, nonché di apprezzarne l’idoneità a garantire il soddisfacimento del credito in caso di inadempimento.
Pertanto, pronunciando il principio di diritto di cui sopra, la Suprema Corte, in accoglimento dei motivi proposti dalla società X cassava la sentenza di gravame, rinviando alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.